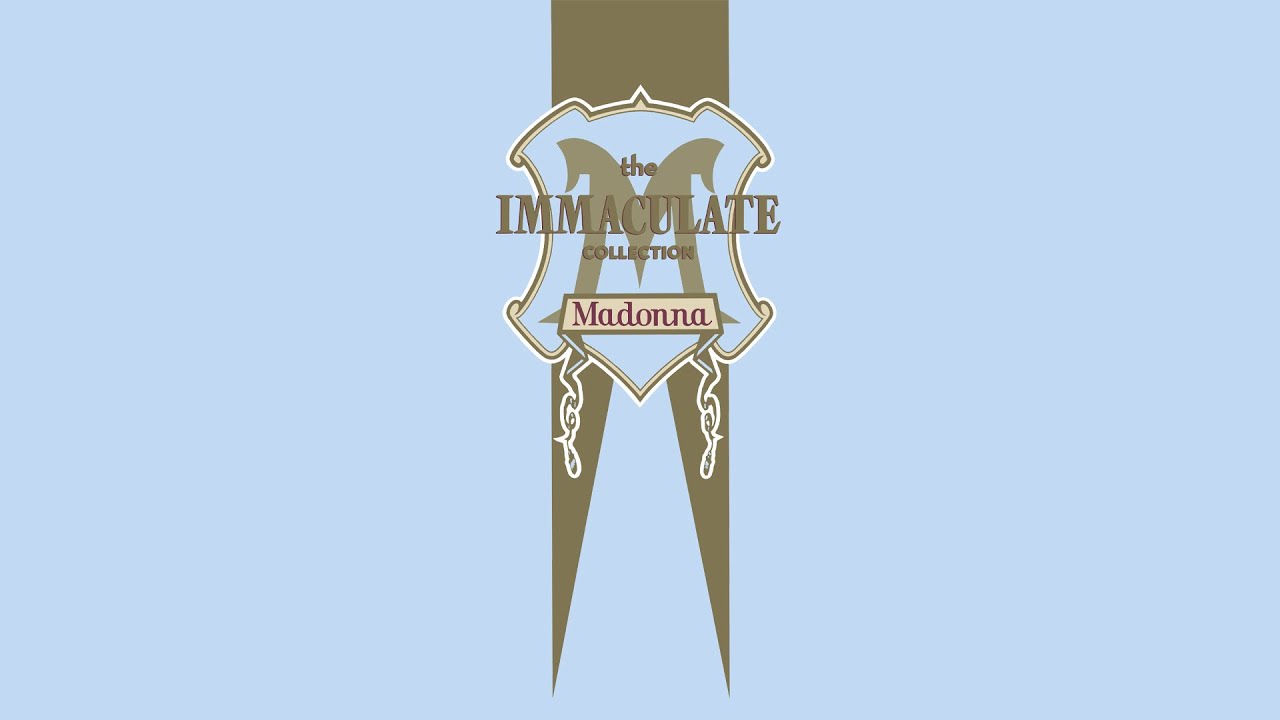Quando ho iniziato a guardare “Adolescence”, sapevo che temi ormai “classici” – bullismo, ansia di esclusione, il bisogno disperato di piacere e di essere visibili – sarebbero stati trattati con una durezza piuttosto intensa. Ma non è di questo che voglio parlare perché c’è qualcosa di più crudo, più violento su cui riflettere: il modo in cui gli “adulti” siano inconsapevolmente complici di queste dinamiche, nonché (f)autori stessi.

Era chiaro già dalla prima puntata come quei gesti esasperati, quegli scontri tra insicurezze e necessità basiche, quelle lotte per la rilevanza sociale (“sicuramente tu eri molto popolare a scuola” – il mantra dei primi 10 minuti), che la serie attribuisce agli adolescenti, abbiano invece delle eco nei modi di fare, di pensare e di agire delle persone adulte che abbiamo attorno.
Inclusi noi, ovviamente.
E qui nasce il primo interrogativo: è davvero così semplice tracciare una linea di separazione? Quei problemi, in fondo, sono davvero così lontani dal nostro mondo (adulto)?


Quando mi dissero che questa serie provoca un certo disagio nello spettatore, non pensavo onestamente a questi livelli.
Con una lente più critica, non è possibile guardare questa serie pensando che il problema siano solo generazionale. La differenza tra teenager e una società adulta sta diventando sfumata, è quasi impercettibile. Mi chiedo, a questo punto, se sia possibile uscire da questo circolo vizioso o se la nostra apparente distanza non sia solo un’illusione forzata, un modo per non confrontarci con la verità: i crimini morali che noi per primi commettiamo ogni giorno, per quanto non punibili dalla legge, ci stanno lentamente trasformando in qualcosa di altrettanto deprecabile.


Sono anche stanco di dover sempre dedurre dai social il trend dei comportamenti umani (e incriminarli), quando in realtà basta guardarsi attorno. È sufficiente ascoltare una conversazione, partecipare a una riunione di lavoro, fare una cena con amici o assistere a una riunione familiare. C’è chi monopolizza il discorso per raccontare i propri (presunti) successi, chi si assicura che tutti notino quanto sia impegnato e indispensabile, chi si erge a figura imprescindibile nelle dinamiche collettive (sono certo, che a questo punto, hai già visualizzato almeno un paio di soggetti che rispondono a queste caratteristiche e che, se potessi, eviteresti accuratamente). Questi micro-comportamenti, ormai normalizzati, sono il tentativo più basico della costante ricerca di attenzione, di una necessità di validazione che va ben oltre il contesto digitale relegato (con arrogante distacco) solo alla Gen Z.


Eppure, quando si sommano e si normalizzano, questi atteggiamenti si trasformano in un schema più ampio. Il narcisismo quotidiano cresce fino a diventare un’abitudine penetrante: la tendenza a rendere ogni interazione un’occasione per brillare, per dimostrare la propria rilevanza, per occupare spazio (vitale) a scapito degli altri. Questo passaggio dal micro al macro è insidioso, perché non viene assolutamente percepito come un problema. È solo il “modo in cui si fanno le cose”, che però erode la qualità delle relazioni e alimenta invidie silenziose.
Quando però l’occhio del regista irrompe nel punto di vista degli adulti, viene messa in luce la fragilità di una generazione dove non c’è stata evoluzione, illusa di essere al sicuro solo perché non ha un palcoscenico (o dovrei dire una piattaforma) che può rendere facilmente evidenti i fallimenti.
Sono invece le telecamere meno digitali dello sguardo sociale a far collare la facciata di normalità.

Così, mentre il peso del giudizio schiaccia i genitori, i figli mostrano una sorprendente (e irritante) capacità di reagire con lucidità, incarnando l’equilibrio che agli adulti ormai sfugge.

E’ così che ho capito che la storia che si stava sviluppando davanti a me potesse avere una lettura diversa: la linea di separazione tra giovani e adulti, tra immaturi e maturi, è più sottile di quanto vogliamo credere.
Forse non esiste nemmeno.
E ho iniziato a riflettere su quanto temi come l’invidia sociale o la costante ricerca di visibilità e di rilevanza non siano esclusive di un mondo acerbo. Al contrario, le persone adulte stesse sono intrappolate in una (rin)corsa infinita, che le rende sempre meno capaci di insegnare e trasmettere valori diversi alle nuove generazioni.
E in queste sabbie mobili emotive, entra in gioco anche la F.O.M.O.
La paura di essere esclusi, di non essere rilevanti, di perdere un’occasione di visibilità o di successo professionale. Di non trovare un biglietto per il concerto di Lady Gaga.

Ogni piccola esclusione percepita, ogni momento in cui il nostro ego non viene nutrito, ogni interazione che non ci restituisce l’attenzione che cerchiamo, aggiunge un altro tassello a una spirale di frustrazione. In questa zona grigia il narcisismo quotidiano trova terreno fertile: ci spinge a rincorrere conferme sempre più grandi, ma quando queste non arrivano (o non bastano mai), ci troviamo immersi in un’insoddisfazione sempre più grande. Questa frustrazione, a sua volta, ci rende più cinici, meno disposti a dare agli altri ciò che vorremmo ricevere. Invece di coltivare empatia, finiamo per inaridirci, per incattivirci.

È la stessa dinamica che ho visto in “Adolescence”, quando i personaggi si ritrovano incapaci di vedere oltre il proprio dolore e il proprio desiderio di appartenenza. Solo che, nel caso degli adulti, questa indifferenza prima di sfociare in atti criminali estremi, si insinua nelle piccole decisioni di ogni giorno: scegliere di ignorare le necessità altrui, cercare sempre il proprio tornaconto, evitare qualsiasi sacrificio che non porti un ritorno immediato.
La differenza è che non ci sono telecamere a riprendere i questi “atti quotidiani”.
Ma cioè non implica che siano meno significativi.

POP VIBE: This is what you'll get when you mess with us